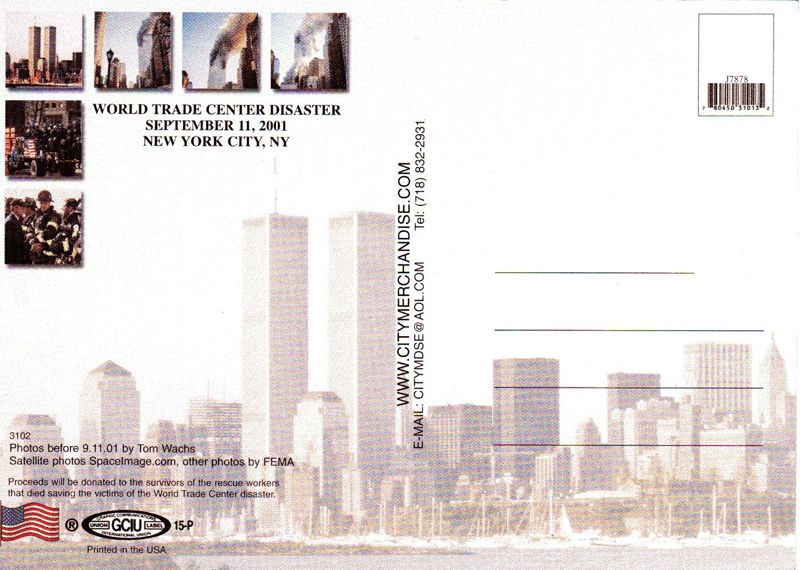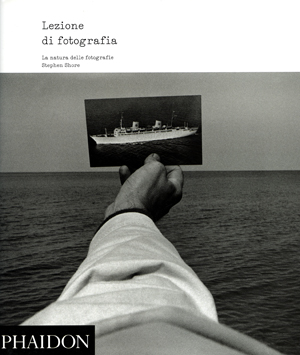L’avranno vista tutti, quest’immagine, ma mi pare valga la pena di affrontarla un attimo in più. Il cosiddetto “Riot Kiss” (bacio tra gli scontri) opera di Richard Lam, è stato pubblicato il 16 giugno del 2011 sul Vancouver Sun a testimonianza di quanto accaduto nella città canadese messa a ferro e fuoco dai tifosi locali dopo aver perso la finale della Stanley Cup di hockey su ghiaccio contro la squadra di Boston.
Di qui a 100 anni questa foto potrebbe ancora reggere al peso degli anni mostrandoci intatto il momento in cui un ragazzo e una ragazza imprevedibilmente si distendono e si baciano, mentre tutt’attorno a loro impazzano la follia, la violenza, le fiamme. Non è il migliore spot possibile per la forza dell’ammore? Non è l’emblema stesso della fotografia che vale più di mille parole? Non è lo stesso del marinaio che bacia l’infermiera di Alfred Eisenstaedt nel giorno in cui termina la 2° Guerra Mondiale? Non è così? No, non lo è: ma lo diventa. O lo diventerebbe, se lasciassimo la foto tranquilla, da sola; se non la ricoprissimo di indiscrezioni, intrufolandoci sempre e per forza dietro le quinte, quando non sempre quel guardare-oltre ci porta davvero al di là dell’immagine.
Innanzitutto: della stessa foto si può dare una lettura documentaria e una lettura emblematica. Se si dispone di informazioni collaterali, sia di tipo iconico sia di altra natura (immagini o, invece, resoconti, interviste, filmati etc.) si può tentare di piazzare quest’immagine all’interno di una catena di eventi, di cause e concause – fotografiche, oltre che fattuali – riducendo il numero di illazioni necessarie a spiegare a cosa essa si riferisca. Se invece non si dispone di informazioni (come avviene il più delle volte) la foto continua a comunicare, ma a un livello emblematico: dove ogni singolo elemento diviene categoria generale e astratta. Mi spiego: per una lettura documentaria i due sono: “Scott Johns e Alex Thomas”; per una emblematica sono: un uomo e una donna. Capito?
Proseguo: il contesto passa dall’effettivo: “la strada di Vancouver in preda agli scontri dove – travolti da tifosi e poliziotti – i due cadono a terra”, a un emblematico: questo mondo impazzito e selvaggio. L’azione, letta risalendo i fatti, corrisponde a: “Scott, caduto subito dopo Alex, tenta di ridare coraggio alla fidanzata, in lacrime per il panico e per l’urto con la folla”; quando, letta in senso emblematico, suona: i due si abbandonano al sentimento qualunque cosa avvenga attorno a loro, o – come ha (incredibilmente) commentato il padre di Scott su Facebook: questo vuol dire fare l’amore non la guerra!…
Il motivo che mi spinge a credere che questa foto non conserverà il suo valore emblematico è l’accanimento mediatico, o meglio: l’assortimento mediatico e l’accesso alle sue fonti. Bastava pagare ed ecco spuntare il girato di varie telecamere di sicurezza ad offrirci l’evento immortalato da Richard Lam per Getty Images, visto da altri punti di vista sia spaziali che temporali. Ora sappiamo che un fiume di gente ha travolto i due, che la polizia ha tentato di rialzarli, che lei era sotto shock, che lui ha provato a rincuorarla, che gli si sono avvicinate varie persone. Ma sappiamo anche che Lam ha scattato varie immagini e che solo su una di queste si può vedere il poliziotto, emblema degli scontri, mentre impalla, copre e rimuove dalla memoria collettiva la figura di una donna che nel frattempo si avvicinava per porgere aiuto. Non si può preferire a priori il documento rispetto all’emblema, o viceversa: occorre scegliere in base all’uso.
La forza di certe immagini come quella di Eisenstaedt è che – tolta una manciata di negativi alternativi – non si è saputo granché su chi fossero quel marinaio e quell’infermiera (morta di recente) e il perché o il percome i due si fossero trovati a baciarsi. Scott e Alex, invece, praticamente il giorno dopo erano ospiti dell’emittente canadese CBC riraccontando la loro vicenda nei minimi, pettegoli, costosi, inutili particolari; e affogando, così, nel chiacchiericcio la bella fotografia di Lam. Alla prossima.
© Augusto Pieroni (da FotoCult #79, Agosto 2011)